(Le favole sono cose da l’ attanti)
Fiabe e favole forniscono una rappresentazione del mondo. Le immagini, per quanto inserite in un contesto narrativo, solo marginalmente risultano didascaliche e descrittive. Nelle prime i personaggi (orchi, fate, folletti) sono immaginari, quelli delle favole hanno una connotazione più realistica. Principi e principesse, bambini sventurati, animali con comportamenti antropomorfi, orchi con caratteri umani. Le favole hanno un contenuto morale, predispongono a un comportamento formulato alla fine del racconto (o è desumibile); nell’ambientazione fantastica le fiabe dimostrano invece una minore rigidità nella struttura. Per entrambe si tratta di racconti popolari, per lo più tramandate oralmente, arricchite da immagini semplici, con un contenuto povero e una narrazione elementare. Accompagnavano il sonno dei bambini e i lavori di casa degli adulti, soprattutto femminili. Presenti da sempre nell’ambiente domestico, le più conosciute dell’antichità rimangono quelle di Esopo e Fedro, ma la diffusione la ebbero soprattutto in epoca medievale. I racconti più celebri si perdono nel tempo; delle storie di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Cenerentola è difficile trovare l’origine, ma sono rimaste nella riscrittura di Charles Perrault, i fratelli Grimm, Andersen, Charles Dogson (Alice nel Paese delle Meraviglie). Ma anche di Giambattista Basile, Collodi e Calvino. Nulla è definito in questi racconti, eccetto i caratteri dei protagonisti: personaggi, epoca e luoghi sono collocati nella fantasia e mai nominati direttamente. Il principe non ha nome, la principessa riassume nel suo la purezza (Bianca-neve) e Cenere-ntola per ipotiposi rimanda alle sue origini umili; da qualche parte in un certo tempo c’è un castello, una foresta e una strega sempre cattiva. E’ difficile entrare in una favola ed è ancora più difficle uscirne, non per niente le storie cominciavano dicendo: “stretta la foglia, larga la via”. S’improvvisavano e quelle parole portavano la fantasia in un mondo irreale, erano l’ingresso che preparava l’ascolto. Per quanto riguarda l’impianto narrativo, favole e fiabe sono abbastanza conformi:
-si tratta di vicende inverosimili, per lo più impossibili e i personaggi improbabili o inesistenti;
-hanno un contenuto morale: il mondo è nettamente diviso in buoni o cattivi, furbi o ingenui e non esistono sfumature;
-ripetizione: i motivi ricorrono anche in altre fiabe, rimarcati dal ripetersi di frasi, cantilene e formule magiche;
-lieto fine: i buoni, i principi vengono premiati; le fanciulle del popolo diventano principesse, i giovani coraggiosi sono incoronati e la bontà vince. Nelle fiabe di magia in particolare, l’apoteosi è una costante. Dopo le disgrazie l’eroe trionfa, il bisogno di giustizia è appagato, il popolo che vi si identifica viene soddisfatto.
-didattica: c’è sempre una morale, anche se non espressa chiaramente, che induce a onorare gli anziani, il nucleo familiare, i regnanti, le leggi. Le favole, tutte indiscriminatamente, hanno un carattere calvinista e reazionario.
Le ripetizioni sono un elemento determinante (“C’era una casa piccola piccola”, “Cammina, cammina”, “Tanto, tanto tempo fa”, “Ucci ucci sento odor”). Raccontando più volte lo stesso fatto allungano la storia e dilatano il mistero, richiamano le emozioni. Inizio e fine danno la regola (“C’era una volta”, “E vissero felici e contenti”), numerosi e parimenti ripetitivi sono anche i rituali magici e le filastrocche. La ripetizione è una conferma, crea abitudini e relazioni, luoghi comuni. Come le briciole di Hansel e Gretel, segna il percorso. Ed è esperienza comune nei bambini sentirli chiedere “ancora ancora” mentre si legge loro una storia; la ripetizione allunga il tempo e lo contrae, lo rende familiare e magico. Le filastarocche prima delle vicende rappresentano la gestione di un ritmo e di un tempo. Il tempo della fiaba ha caratteristiche proprie particolari e presenta analogie con il sogno. Non si può collocare in un periodo storico preciso; il suo fluire è irregolare e non lineare. L’imperfetto e l’infinito prevalgono sul presente e sul futuro; se c’è un passato è talmente remoto da perdersi nel tempo e il futuro non è ben precisato, è anteriore. Le fiabe, spesso ambientate nel medioevo (ma non solo), mettevano in risalto l’epica del blasonato o di un cavaliere come un valore e non accennavano alle condizioni popolari. Favole e le fiabe non sono rivoluzionarie, tutt’altro. Le fiabe in particolare vengono collocate in uno spazio temporale irreale, concepite su antiche leggende (con draghi, fate, folletti, animali dotati di parola) in modo da eccitare la fantasia. Portando le immagini fuori dal tempo, fuori da un contesto ordinario, le fantasie prendono l’aspetto di un drago, di una strega, di un orco. Proprio come avviene in certe psicosi. La filastrocca in particolare fa in modo di controllare il materiale straordinario, gli dà una regola, lo disciplina. Come una grammatica del bordo, lo schema narrativo ripercorre una “narrazione di superficie” sulle operazioni logiche che caratterizzano un quadro semiotico (Greimas), sovrapponendo il carattere antropomorfo del fare. Il fare è antropomorfo perché ogni volta che attribuiamo un fare a qualcosa lo umanizziamo (e lo comprendiamo). Greimas spiega la questione con un esempio: “La matita scrive bene”; il fare della matita viene concepito positivamente come un compito inalienabile che il soggetto/oggetto svolge in modo inappuntabile. La regola è che ogni racconto, ogni testo dotato di un incedere narrativo, rende antropomorfe le cose di cui parla per lo stesso fatto di mettere in scena il loro fare. Nella fantasia dei bambini gli oggetti si animano e gli animali parlano, e ciò dipende proprio dall’ordine narrativo che prevale sulla logica e sulle relazioni logiche che chiamiamo reale. Tale struttura del racconto ha un’origine profonda e va al di là della lingua, pur rimanendo un fatto linguistico e discorsivo. Freud sosteneva che quando l’uomo reprime un desiderio, questo ricompare nel sogno durante il sonno e come sintomo durante il giorno. Citava due esempi di sogni collegati alle favole:
a) il sogno di trovarsi nudi in compagnia; a suo parere si origina dal desiderio di spogliarsi davanti ai genitori e produce una sensazione di piacere. Da questo ethos si sarebbe originata la fiaba di Andersen, “I vestiti nuovi dell’imperatore”.
b) Il sogno della morte di un familiare, che Freud collega al desiderio del bambino di uccidere il padre. Posta così la natura della fiaba è evidente una relazione con la catarsi; i personaggi spesso sono adolescenti che trovano la loro strada vincendo il drago e il male. Jung si è spinto oltre; era sua convinzione che ogni essere umano sia naturalmente portato a sviluppare facoltà innate, la cui riuscita dipende da una cooperazione tra inconscio e coscienza. Se questa sinergia si blocca, si verifica una reazione dell’inconscio che si esprime nei sogni, nelle fantasie e nelle fiabe, che hanno tra loro profondi legami nelle diverse culture popolari, al di là delle geografie e dei tempi. Queste relazioni che non hanno confini geografici e temporali sono propriamente gli archetipi. L’inconscio può esprimersi nell’immagine archetipica del bosco o di una foresta che l’eroe deve attraversare. Jung concentra le sue osservazioni anche sui personaggi di contorno come figure archetipiche. Se l’eroe non riesce a procedere e sopraggiunge un vecchio, significa che uno degli archetipi dell’anima o del giudizio stia facendo sentire la sua voce. Da queste considerazioni psicologiche e per quel che riguarda il racconto favolistico, nasce nel 1910 col Catalogo delle fiabe di Aarne, il metodo interpretativo storico-geografico; nel quale ad ogni fiaba venne attribuito un numero, dando luogo a diversi cataloghi regionali e nazionali. Allo stesso Aarne si deve anche un altro metodo di classificazione, basato su un indice dei tipi, poi rivisto e ampliato da Thompson (chiamato metodo di Aarne-Thompson). L’indice raccoglie circa 2500 tipologie definite nelle fiabe, consentendo di descrivere in forma numerica (così catalogandola) ogni fiaba.
Nel 1946 veniva pubblicato in russo il saggio di Vladimir Propp “Le radici storiche dei racconti di fate” (tradotto in italiano nel 1949). La conclusione a cui Propp giunse è che la maggior parte degli elementi delle fiabe risalgano a riti e miti primitivi, e in particolare al rito d’iniziazione e alla messa in scena della morte. Le fiabe popolari, soprattutto quelle di magia, sarebbero la memoria del rito d’iniziazione delle comunità primitive. Una pantomima che ripercorre quella fondamentale esperienza in cui i giovani morivano simbolicamente (e con l’aiuto di sostanze stupefacenti) per rinascere sotto la guida di uno stregone alla vita adulta. Col passare del tempo il rito d’iniziazione non si celebrò più ma rimase il ricordo, tramandato oralmente dagli anziani. Il rito si è poi trasformato in una fiaba.

Approccio analogo ebbero i fratelli Grimm. Jacob e Wilhelm partirono dall’idea che ogni popolo abbia un’anima che si esprime nella lingua, nella poesia, nei racconti. Col tempo è andato perduta una parte della lingua, soprattutto nei ceti elevati, e le radici possono essere ritrovate negli strati sociali più bassi, nei quali il racconto orale, la tradizione ha mantenuto un certo valore. Non solo le favole, ma proverbi e modi di dire raccontano il passato di una comunità. In questa ottica, le fiabe si presentano come i resti dell’autentica cultura di un popolo. Nel 1812 e nel 1815 i Grimm pubblicarono due volumi dei Kinder und Hausmärchen, 156 fiabe che formarono il punto di partenza per lo studio dei racconti e delle fiabe popolari. Convinti dal principio che le fiabe fossero tutte di origine tedesca, per spiegare le affinità con i racconti di altre culture ipotizzarono (dal 1819) un passato indoeuropeo. Consideravano le fiabe come una rimanenza di miti antichi sopravvissuti nella memoria popolare e tramandati oralmente; Jacob Grimm così scriveva nel 1812: “Sono fermamente convinto che tutte le fiabe della nostra raccolta … venivano narrate già millenni fa … in questo senso tutte le fiabe si sono codificate come sono da lunghissimo tempo, mentre si spostano di qua e di là in infinite variazioni”. Jung concordava pienamente con quel che sostenevano i Grimm. Le fiabe sono l’espressione più genuina e pura dei processi dell’inconscio collettivo, cioè di quel deposito collettivo che si è sviluppato su una predisposizione comune ad organizzare in maniera simile le esperienze di ogni generazione che si è succeduta. Predisposizioni mentali ed esperienze che attraversano i confini geografici e temporali sono la base per la formazione di quelle immagini particolari, presenti nell’inconscio collettivo, che costituiscono sedimentazioni psichiche stabili di esperienze eterogenee. Queste immagini che hanno assorbito una struttura universale sono gli archetipi (“L’archetipo è la tendenza a formare singole rappresentazioni di uno stesso motivo che, pur nelle loro variazioni individuali … continuano a derivare dallo stesso motivo fondamentale… la loro origine è ignota e si riproducono in ogni tempo e in qualunque parte del mondo, anche laddove bisogna escludere qualsiasi fattore di trasmissione ereditaria diretta”; L’uomo e i suoi simboli).
Se consideriamo le definizioni dell’inconscio collettivo e degli archetipi, ci viene facile comprendere perché Jung abbia ampliato le ricerche al mondo della fiaba. La fiaba è un prodotto della fantasia; assorbe ed esprime desideri, emozioni, aspirazioni, speranze comuni. Non c’è popolo che, assieme alla mitologia, non abbia anche fiabe e favole. In tutte si riscontra una somiglianza narrativa, motivi costanti e topoi privi decontaminazioni, pur nelle varianti locali. Della storia di Cappuccetto Rosso esistono oltre 40 riscritture; di Cenerentola se ne trovano 345 in Europa, in Africa e in Asia (Cendrillon in Francia, Askungen in Svezia, Aschenputtel in Germania, Guidskoen in Danimarca, Ashiepattle in Scozia).
La costante di motivi che si ripresentano, avvalora l’idea che la fiaba rappresenti un prodotto dell’anima universale comune a tutti i popoli e in ogni epoca. Le fiabe rimandano ai processi dell’inconscio collettivo, perché attraverso il ripetersi (in spazi e tempi distanti e diversi) degli stessi temi, danno una forma all’archetipo. A differenza del mito, la fiaba è scarsamente alterata dalle sedimentazioni culturali e rappresenta gli archetipi in una forma pura. Attraverso il campo dell’immaginario, la fiaba accomuna e avvicina civiltà e culture lontane, le sue costanti spiegano almeno in parte le comunanze di pensieri, emozioni, aspirazioni.
Favole e fiabe contengono dunque elementi ancestrali e si esprimono con caratteri comuni. Vladimir Propp studiò proprio le origini storiche della fiaba nelle società tribali in riferimento al rito di iniziazione e ne codificò una struttura generale che propose come modello di tutte le narrazioni. Nel suo studio Morfologia della fiaba, appuntò lo schema che segue, identificando 31 funzioni (inalterabili nell’ordine). Ogni funzione rappresenta una precisa situazione nello svolgimento della trama di una fiaba, riferendosi in particolare ai personaggi e ai loro specifici ruoli (l’eroe e il suo antagonista, il principe e il drago, la principessa e la strega). Nell’analisi di Propp prevale l’azione, è più importante come si comporta e non chi è il personaggio: se l’eroe è una fanciulla, un principe o un orfano è irrilevante; è l’azione che l’eroe compie e non le sue caratteristiche particolari a determinare la trama.
[…]
Lo stesso ruolo può essere svolto da più personaggi, oppure uno dei personaggi può rivestire più ruoli. Il protagonista si fonde con l’azione, il fare svilisce l’identità e se la motivazione è forte domina il carattere dell’azione che finisce per prevalere sulle identità. La linguistica e la semiotica si sono concentrate proprio su questo aspetto delle narrazione, puntualizzando un modello “attanziale” (delineato da Algirdas Julien Greimas nel 1966). L’attante è il soggetto che compie l’azione indicata dal verbo; è un elemento nominale che insieme a un verbo dà luogo a una frase. Gli attanti non sono costretti a compiere un’azione, possono anche subirla. Il concetto di attante è fondamentale non solo per i diversi generi letterari, ma anche per la sceggiatura di un film, il canovaccio di una rappresentazione teatrale, di un discorso pubblicitario o elettorale.
La semiotica ortodossa focalizzava tre elementi fondamentali, il soggetto (può essere colui che agisce o che si caratterizza in relazione all’oggetto), l’oggetto di valore e il destinante. Sulla base di quella prima elaborazione il modello attanziale di Greimas prevede le seguenti categorie:
1) il soggetto è colui che agisce per conquistare l’oggetto (confluenza dell’azione del soggetto);
2) nel suo muovere all’oggetto, il soggetto dà luogo a un’azione con un contenuto;
3) il soggetto assume una familiarità con l’oggetto;
4) agisce sulla base di un mandato (se tende all’oggetto è perché qualcuno lo ha spinto a muoversi);
5) ottiene una ricompensa o una punizione.
Accanto al rapporto soggetto-oggetto si delineano altre figure: il destinatore (che pone l’oggetto come oggetto di desiderio e gli conferisce un valore) e il destinatario (che è chi ottiene qualche beneficio dall’oggetto), l’aiutante e l’oppositore (che si delineano in base alle azioni che il soggetto compie per impossessarsi dell’oggetto).
Gli attanti messi in rilievo da Greimas sono delineati a seconda delle funzioni in quattro tipi […] Il modello ricorda quello di Propp. Se ci spostiamo sul livello della narrazione, gli attanti si definiscono in relazione a soggetto e oggetto, e destinante e destinatario. A un attante non corrisponde necessariamente un attore, ma può succedere che per un attante vi siano più attori. L’attante non è quindi una figura definibile, esiste in relazione agli altri attanti e alle competenze del soggetto e della sua capacità a fare. L’attante che possiede un ruolo tematico e ha un carattere narrativo è l’attore o un personaggio/cosa significativo. Nella sceneggiatura l’attante è un elemento che vale per il posto che occupa nella narrazione e per il contributo che le dà. L’attante si differenzia dal personaggio come persona e dal personaggio come ruolo, in quanto vale per la sua funzione e si caratterizza sulla base di categorie opposte: attivo o passivo, rivoluzionario o reazionario, protagonista o antagonista.
Come si vede dallo schema si tratta di una grammatica narrativa di superficie (secondo le Tre regole della cultura occidentale). Si ha una “narratività di superficie” quando alle operazioni logiche che determinano il quadrato semiotico (Greimas) viene sovrapposta la nozione antropomorfa del fare. Il fare è considerato antropomorfo in quanto ogni volta che attribuiamo un fare ad un oggetto lo trasformiamo in qualcosa di umano. Greimas (come ho già appuntato, ma la questione merita un approfondimento) porta ad esempio l’enunciato “la matita scrive bene”, nel quale il fare della matita viene considerato qualcosa di positivo, come un compito assegnato alla cosa e che la cosa svolge con competenza. Sottolineando che ogni storia dotata di una dimensione narrativa renda antropomorfi soggetti e oggetti (persone e cose) per lo stesso fatto di mettere in scena il loro fare.

Analizzando un racconto si deve procedere con ordine e seguendo lo schema. Si parte introducendo una distinzione fra l’intreccio delle vicende nell’ordine in cui si presentano e la sequenza delle relazioni temporali e causali. Greimas riprende il termine attante da Tesnière; gli enunciati narrativi formano una serie ordinata, ricostruibile a ritroso per induzione o assimilazione. Ciò significa che nella fabula ogni enunciato è un elemento necessario all’enunciato narrativo che segue; ma anche che posto un enunciato narrativo, possiamo risalire agli enunciati che lo precedono. Per questo motivo una storia si capisce veramente soltanto alla fine e procura quello strano piacere di sazietà.
Gli enunciati narrativi. Gli enunciati descrittivi possono essere a) trasformativi o di fare quando descrivono un evento che trasforma radicalmente una situazione (“Il drago rapisce la principessa”) b) di stato o di essere quando descrivono la situazione (se attribuiscono una proprietà sono attributivi, come “Il drago è vorace”). Di altra natura rispetto agli enunciati descrittivi sono quelli modali, nei quali vi è un predicato modale e cioè un predicato che si applica a un altro predicato (“Il cavaliere può uccidere il drago”). Per Greimas sono predicati modali dovere, volere, potere, sapere, fare e essere. Questi enunciati possono essere considerati come attributivi in quanto attribuiscono all’agente un oggetto modale. Gli enunciati narrativi strutturano il discorso in due modi: 1) a due attanti (“Il cavaliere uccide il drago”), 2) a tre attanti (“L’oste dice al cavaliere dove si trova il drago”). Questo genere di rappresentazione è chiamata da Greimas Del Senso. 3) Si possono però presentare entrambi gli enunciati, come congiunzioni e disgiunzioni di soggetto e oggetto (“Il cavaliere libera la principessa dal drago”).
L’estensione al racconto nel suo insieme o comunque a sintagmi narrativi che si succedono secondo sequenza, risente dello schema di Vladimir Propp. In “Morfologia della fiaba” del 1928, Propp chiamava funzione l’azione di un personaggio considerato per il significato che assume nella vicenda (allontanamento, divieto, infrazione, partenza, lotta, vittoria). Per Propp non tutti i caratteri della fiaba di magia si presentano in tutte le fiabe, ma se sono presenti seguono comunque un ordine rigido. Identifica sette ruoli per i personaggi della fiaba: antagonista, donatore, aiutante, re o principessa, mandante, eroe, falso eroe. Funzioni e ruoli proppiani sono maggiormente sfumati e astratti nelle analisi di Greimas, in vista dell’estensione dell’analisi dalla fiaba in riferimento agli altri generi di racconto.
Inizialmente Greimas distingue due tipi di sintagmi narrativi: a) il contratto, in cui il destinante passa un oggetto modale (dovere, volere) a un destinatario che diventa così soggetto di un progetto narrativo b) la prova, in cui il soggetto si confronta con l’opponente per la realizzazione del progetto (unione con l’oggetto). Si distinguono tre tipi di prove: 1) qualificante 2) decisiva 3) glorificante. Nella prova qualificante il soggetto manifesta le qualità per superare la prova successiva. Nella prova decisiva ha luogo un confronto fra il soggetto e l’antisoggetto; il vincitore s’impossessa dell’oggetto per cui ha lottato. Nell’ultima prova il soggetto si confronta direttamente con l’antisoggetto, viene riconosciuto e premiato (l’antisoggetto sarà punito).
Greimas distingue anche quattro strutture modali a) fare-fare b) essere-fare c) fare-essere d) essere-essere, a cui corrispondono quattro processi della struttura di un racconto: 1) manipolazione 2) competenza 3) performanza 4) sanzione. Poiché competenza e performanza danno luogo all’azione, Greimas identifica la seguente struttura a tre fasi chiamandola schema narrativo: x) manipolazione y) azione z) sanzione nella manipolazione. Nell’azione il soggetto, che deve avere una competenza per padroneggiare la situazione, affronta la performanza acquisendo o non acquisendo l’abilità per fronteggiarla. Nella sanzione il soggetto e la sua azione vengono ricompensati. L’applicabilità dello schema narrativo ai diversi ambiti sociali e non solo letterari, lo presenta come un carattere determinante dell’immaginario.
[…]
Il percorso narrativo del soggetto. I sintagmi descritti delineano il racconto come un percorso narrativo del soggetto. Il soggetto all’inizio del racconto è lontano dall’oggetto. Questo soggetto etereo (dal punto di vista della corposità descrittiva del carattere e dell’azione) non ha ancora la maturità narrativa per completare il suo progetto (e unirsi con l’oggetto); acquisisce le competenze necessarie a completare il programma diventando soggetto attualizzato (potere e sapere sono facoltà attualizzanti). In seguito il soggetto procede per il suo iter letterario e si unisce con l’oggetto diventando un soggetto con un carattere definito.
1) Gli attanti. I nomi degli attanti per lo più derivano dagli enunciati narrativi, come enunciati a due o tre attanti. Nell’enunciato a due attanti troviamo soggetto e oggetto; in quello a tre attanti sono presenti destinante, oggetto, destinatario. In “Del Senso” a tali attanti si aggiungono l’aiutante e l’opponente ispirati a Propp; e abbiamo quindi tre coppie di attanti: soggetto e oggetto, destinante e destinatario, aiutante e opponente. In “Del Senso 2” troviamo invece: a) quattro attanti positivi (soggetto, oggetto, destinante, destinatario) b) gli speculari negativi (antisoggetto, oggetto negativo, antidestinante, antidestinatario).
2) Le modalità. Greimas non distinuge solo in modalità virtualizzanti, attualizzanti e realizzanti, ma sottolinea anche le modalità aletiche: potere e dovere quando si attribuiscono all’essere (ad affermazioni vere-false-verosimili) modalità deontiche, potere e dovere quando si applicano al fare.
3) La veridizione. La categoria modale della veridizione è articolata su un quadrato semiotico in cui i due contrari sono essere e sembrare. Lo schema dell’immanenza mette in relazione essere a non essere, quello della manifestazione unisce sembrare a non sembrare. Le modalità veridittive si determinano sui quattro lati del quadrato: essere + sembrare produce la verità; non essere + non sembrare dà luogo alla falsità; dall’essere + non sembrare scaturisce il segreto; da sembrare + non essere si origina la menzogna. La definizione di ciò che è falso non è chiara, ma possiamo spiegarla come un destinante che pronunci un enunciato simile: “Non è così e non sembra così”. La locuzione determina appunto il falso. In Greimass e Propp è evidente il superamento della poetica di Aristotele, della verità come verosimiglianza e della verità come qualcosa di esclusivo nell’enunciazione (De Interpretazione). La veridizione è qualcosa di autonomo e istituisce la verità della storia. Essa complica la scena applicandosi agli attanti (soggetto e antisoggetto) alla loro competenza (autentica o illusoria) o ai sintagmi narrativi (contratto ingannevole). La sanzione si serve delle modalità veridittive per il riconoscimento del soggetto e lo smascheramento dell’antisoggetto.
4) Semiotica discorsiva. Il discorso del racconto è separato dalla sua struttura; possiamo avere racconti con la stessa struttura ma che utilizzano personaggi diversi o un diverso ambiente. Decontestualizziamo ad esempio Cenerentola in una moderna città in luogo del bosco. Tra grammatica narrativa e semiotica discorsiva passa la medesima differenza rinvenuta fra attanti e attori. Gli attanti sono attualità narrative a carattere sintattico, gli attori presenze discorsive in cui è rilevante l’aspetto semantico. Gli attanti prevalgono nel contesto narrativo e lo rendono riconoscibile anche quando si stravolge il contesto. Come accade per le caricature o la satira, dove benché deformato rimangono sempre individuabili il soggetto e la scena.
[…]
Gli attanti sono i veri protagonisti delle favole e svolgono funzioni diverse. Abbiamo visto schematicamente che sono riconducibili a otto: quattro positivi (soggetto, oggetto, destinante, destinatario) e quattro negativi (antisoggetto, oggetto negativo, antidestinante, antidestinatario). Prevalgono però sulla scena soggetto e antagonista, non per loro naturale propensione ad accentrare l’attenzione narrativa, ma per l’innato bisogno di giustizia che porta da sempre a dividere il mondo in buoni e cattivi. E dunque: “attanti a quei due”.
Da Per me Biancaneve gliela dava ai sette nani (tutto quello che non vi dicono sulle favole)




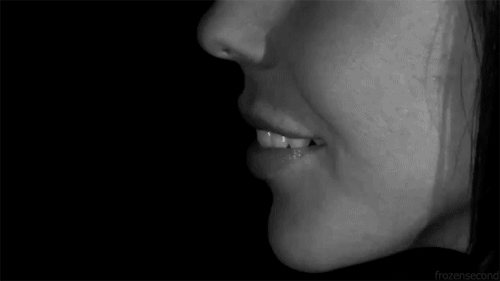

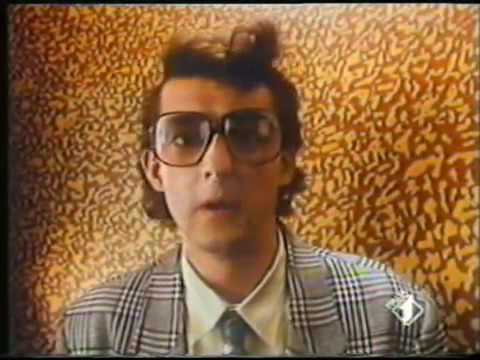




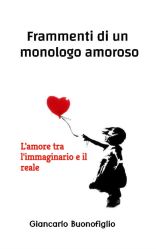


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.