Il non finire mai è il carattere delle cose. Cambiano, perdono di senso ma solo per acquisirne un altro, si rinnovano e non smettono di esistere; finisce un senso e ne comincia un altro. Decontestualizzare mi sembra la parola corretta; la decontestualizzazione non è la distruzione della cosa, ma lo spostamento in un altro luogo. Nello spostamento non c’è una perdita di senso, piuttosto la sua trasformazione.

La vita intima della cosa (ciò che la qualifica nella funzione) non è nell’uso-per dato dalla mano (Das Wesen der Hand, come Vorhandenheit e Zuhandenheit). Nello spostamento le mani compongono e dispongono, a volte indispongono. La scomposizione è il fenomeno più radicale dello spostamento. Stai composto, quante volte lo abbiamo sentito dire? E puntuale arrivava la sberla, la mano appunto che riordinava contestualizzando il corpo del bambino in uno spazio comune. Per le mamme voleva dire: riordina, ogni cosa deve stare al suo posto. Il rafforzativo confermava la regola: ri-, ordina nuovamente; la ripetizione è già un imperativo. Ma i bimbi sono disordinati e disinvolti per una naturale avversione alle regole, anarchici con le imposizioni, ostinati con le prescrizioni; e infatti si indispongono, scompongono e rompono gli oggetti. Oltre naturalmente gli impronunciabili. Cercano un senso al di là di quello già dato, perché alla curiosità dell’infanzia l’impronta dei grandi davvero non basta. Scomporre vuol dire non tanto dividere una cosa, ma metterla fuori posto, fuori dall’ordine a cui le mani l’hanno abituata. Le abitudini diventano prima regole e poi leggi, non è un argomento da sottovalutare; e infatti i fanciulli non lo sottovalutano affatto. Assimilano il Begriff, la struttura intellettuale che rileva (Aufhebend) l’afferrare, begreifen, il comprendere prendendo, padroneggiando e manipolando le cose. Ma ne diffidano fortemente. La mano di Heidegger, che si muove con la callidità del linguaggio è ciò che organizza gli oggetti secondo un ordine. La sua è però una mano adulta, intellettualmente educata a ricomporre il tempo (perché di quello si tratta) secondo il prima e il poi. Apparecchiano la tavola in cui sistemano le cose così come devono stare. Il linguaggio comunica, manipola, prende, proprio come fa la mano toccando quel che la lingua raccoglie. La mano anticipa la parola e dà luogo a una metafisica dell’afferramento imponendo all’oggetto un’intenzionalità; questa cosa la chiamiamo comprensione, ed è la versione scolorita del Begriff. Afferrando le cose le ordiniamo, ossia diamo loro un ordine (ricordate quando le mamme dicevano fai questa cosa? Di norma il dito era puntato e la mano vagamente minacciosa). Le mani assegnano non solo la funzione all’oggetto ma lo definiscono nello spazio e lo limitano nel tempo. In Sein und Zeit sembra che le cose debbano prendere ordini dalle mani e così non è. Heidegger non è un profanatore della cultura, è più simile a un maggiordomo scrupoloso nella pulizia e metodico nel riporre le cose al proprio posto; l’uomo (Dasein) continua ad essere la misura delle cose e le cose non esistono se non in funzione del soggetto. La Fenomenologia aveva però fatto qualcosa di diverso dislocando il soggetto: il decentramento comporta una radicale distorsione anche dell’oggetto, proprio come accade ai bambini che si meravigliano per quello che vedono e non per ciò che sentono dire; esiste qualcosa fuori di loro e questa cosa pur dilatata dalla fantasia la chiamano reale. La realtà piace ai bimbi più delle favole. Li colloca, li definisce, li dimensiona non al di là, ma nelle cose. E li fa sentire vivi. Se esiste qualcosa, la sua esistenza si conferma non in una relazione col nostro percepirla (la percezione è una rappresentazione), ma in autonomia, al di là di quello che siamo. Le cose sono cose e possono fare a meno della nostra presenza.
Questo slideshow richiede JavaScript.
La realtà, essendo ciò per cui una cosa è quella e non un’altra, esiste e di vita propria, indipendentemente dall’essere conosciuta o manipolata; la funzione è un accidente e mai qualcosa di sostanziale. Ma gli universali universalizzano collocando gli oggetti in un universo di senso, che vuol dire in un verso solo. Le idee quando pensano il reale secondo la mansione vanificano le parole (il nome che diamo alla cosa) in un vuoto nominalismo. Il reale esiste, è pensabile (a condizione che si conformi il pensiero all’interno dei limiti delle cose, in re o post rem), è esprimibile, ha una collocazione definita nello spazio e nel tempo. Si definisce come specie o categoria ma solo nei contorni dell’ecceità, che è “la causa, non della singolarità in genere, ma di questa singolarità nella sua particolare determinazione, cioè in quanto è proprio questa” (haec determinate). Il pericolo dell’andare oltre, nell’universale, è di farsi travolgere dall’intenzionalità del senso.

Torniamo alla decontestualizzazione: una scarpa al piede la identifichiamo per quello specifico uso, posta su una parete diventa una scultura, un oggetto puramente estetico; decontestualizzato l’oggetto si libera dalla presa delle mani e del linguaggio, svincolandosi dall’ordine morale prima che da quello intellettuale. Scultura di cattivo gusto il più delle volte, ma con Cattelan abbiamo visto di peggio. In Heidegger c’è la conferma di tutta quanta la nostra storia culturale, quella che fa dell’uomo la misura delle cose, che gli ruotano attorno come alla causa finale. Non è un discorso complesso: immaginate Belen in un centro anziani e capiamo in che modo avvenga l’attrazione. Eppure la tecnologia dimostra proprio il contrario: le cose come oggetti con una propria ontologia sono qualcosa di intimamente eversivo; la tecnica ha tecnologizzato le persone vincolandole alle cose, l’ideologia le ha rese schiave di un’idea, la lingua della rete o delle televisioni ha modificato in profondità il linguaggio, l’arte ha decontestualizzato le cose facendone appunto altro. Questo altro nel quale l’oggetto prende una diversa forma, senso o contenuto può essere affettivo, estetico, pratico. Le cose non passano dall’essere al non essere, non finiscono mai; si svincolano dalle mani e diventano semplicemente altro, vanno a vivere altrove. Cambia la funzione e la funzione è ciò che dava loro il senso. Quando Eraclito scrive (o meglio qualcuno per lui) πάντα ῥεῖ, oltre a delineare la sceneggiatura del noto film con Robin Williams, intende che ad ogni istante che passa non siamo più quelli di prima, che cambiamo, diventiamo difformi, deformiamo. L’argomento non è inconsistente, parliamo di piccoli frammenti di tempo come se nulla fossero; eppure provate a rispondere un attimo! alla consorte quando vi chiede di svolgere un compito, e vedrete che quell’istante viene recepito come come un’era glaciale. L’attimo sarà pure fuggente, ma non è comunque mai negoziabile.
Le mani afferrano gli oggetti e danno loro un senso, si muovono nell’orizzonte del possibile e quando si cimentano con l’impossibile non bastano più. I detrattori parlano allora di adynaton, affermando l’impossibilità che una cosa avvenga subordinandone l’avverarsi a un altro fatto ritenuto impossibile. L’argomento è però debole, retorico, funziona nel linguaggio pratico ma la vita è un’altra cosa. L’impossibile non è il limite dell’oggetto, piuttosto la sua possibilità di trasformarsi o deformarsi in altro.
Dando il nome a uno oggetto lo individuiamo in quel che serve, attribuiamo una categoria e la categoria è un universale che identifica la cosa, la rende identica a se stessa. Con le parole istituiamo una mistica dell’oggetto e dunque una metafisica. E tuttavia la realtà è ciò per cui una cosa è quella e non un’altra, esiste indipendentemente dall’essere conosciuta. Le idee quando pensano l’ideale come reale vanificano le parole in un vuoto nominalismo. Il reale esiste, è pensabile (a condizione che si conformi il pensiero all’interno dei limiti delle cose, in re o post rem), è esprimibile, ha una collocazione definita nello spazio e nel tempo. Si definisce come specie o categoria ma solo nei contorni dell’ecceità, che è “la causa, non della singolarità in genere, ma della singolarità nella sua particolare determinazione, cioè in quanto è proprio questa”. Il pericolo dell’andare oltre è di cadere nella rete della metafisica e dell’ideologia, dell’abitudine intellettuale a disporre le cose assecondando un ordine. Questo vale tanto nella vita ordinaria, quanto nella sua dilatazione sociale: fuori dal reale non ci sono che le parole e il linguaggio della politica (per la relazione che sussiste tra l’universale e il banale esercizio del potere) lo dimostra pienamente; manca l’arrosto e vende il fumo. C’è una regola in cucina e le mamme la esercitano per lo più con eleganza: gli aromi coprono gli odori di una pietanza deteriorata, rendono appetibile l’alimento andato a male o sgradito ai bambini. E così poste le cose in un senso che rende impossibile l’altro, non solo ne decretano la fine contornandone i confini, ma si comportano come gli imbonitori medievali che si fermavano nelle piazze trafficando le piume dell’arcangelo Gabriello a una plebe ignorante, convinta di sfamarsi con l’arrosto mentre in realtà mangiava la merda.
Nota personale: non so com’è, ma pur nella veneranda devo avere un rigurgito d’infanzia; non ho un Io tautologico, non ragiono in termini idealistici e penso che la verità non necessiti della mia presenza. Sono certo che possa fare a meno della mia ontologia. Non sono un metafisico e la veritas (come) est adaequatio rei et intellectus (la verità come corrispondenza della cosa e dell’intelletto) mi sembra una forma di delirio. E così guardo alle cose per quello che sono (come i paradossali oggetti delle foto) e per lo più mi piacciono, le spoglio e le scopro ogni giorno. E ogni giorno mi sembrano meravigliose.












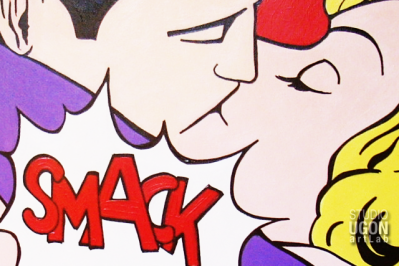

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.